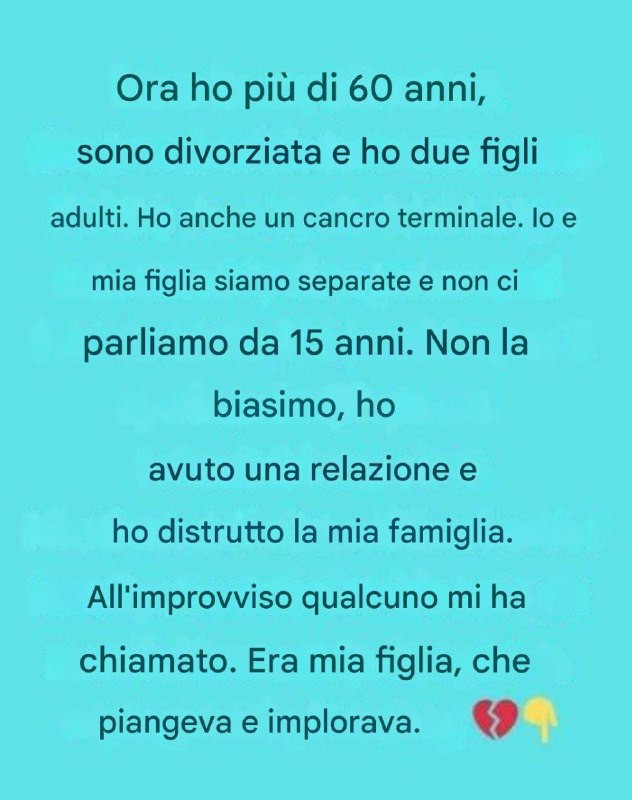Quindici anni. Mi aveva escluso per così tanto tempo: niente email, niente compleanni, niente contatti. E ora era lì, non solo a contattarmi, ma ad aver bisogno di me.
“Cosa posso fare?” chiesi con la voce rotta.
“Non lo so”, urlò. “Ho solo bisogno di papà. Elijah non ha un nonno. Forse… forse è ora.”
Le promisi che sarei arrivato entro un’ora.
Non le avevo detto del mio cancro, non allora. Non potevo aggiungere quel peso al suo. Forse, se questo fosse stato l’ultimo capitolo della mia vita, avrei potuto provare a scriverlo in modo diverso. Quando sono entrato nella stanza d’ospedale e l’ho vista, ho fatto fatica a riconoscerla. Lo stesso sguardo feroce che aveva quando aveva difeso il fratellino, ma ora mescolato alla stanchezza. Una stanchezza profonda, agghiacciante.
Alzò lo sguardo, si fece coraggio per un attimo, poi si alzò e si lasciò cadere tra le mie braccia.
All’inizio non parlammo molto. Ci tenevamo solo per mano.
Elijah dormiva a letto: pallido, con occhiaie, con cavi e monitor collegati al suo piccolo corpo. Aveva circa sette anni.
“È un combattente”, sussurrò, scostandogli i capelli. “Stanno facendo degli esami… c’è qualcosa che non va nel suo sistema immunitario”.
Ero senza parole, così mi sedetti accanto a lui e gli dissi: “Parlami di lui”.
Parlò per ore.